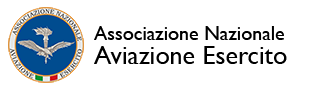di Roberto Sangalli
Giornata namibiana tipica: sereno, molto caldo secco, leggermente ventilato, abbastanza da sollevare il solito, sottile strato di polvere che tanto male fa ai sofisticati meccanismi rotanti dei nostri bianchi elicotteri.
La “linea” di volo è impegnata nel quotidiano tran-tran dei giorni tranquilli.
I nostri quattro elicotteri, di cui due sempre giornalmente pronti, uno per le missioni schedulate, l’altro per le “MEDEVAC”, sembrano sonnecchiare al fresco relativo dell’hangar.
Il periodo critico che abbiamo vissuto nei primi mesi della missione ha lasciato il posto alla routine, anche se quaggiù in ogni momento può succedere sempre qualcosa.
Ed infatti, a conferma di ciò, dalla radio arriva improvvisa, alle 12.00, una chiamata del Comando:
“Medevac ad Opumanda, diversi morti e feriti, probabilmente saltati su un campo minato.”
La crew di medevac, cap. Nicola Peres, serg. maggiore Ennio Galiussi, studiate le carte ed aperto il piano di volo, è subito trasportata , dal compound di Helitaly, in linea.
Nel frattempo il sottoscritto, capo velivolo, ha già provveduto a spingere sul piazzale il 205 precedentemente ispezionato ed attrezzato con barelle e quant’altro necessario alla missione.
Subito a bordo, messa in moto e via, prua a sud, destinazione un villaggio nei pressi di un distaccamento delle truppe UNTAG malesi.
Il nostro target non è facilmente raggiungibile: 35/40 primi di volo su di un territorio uniformemente piatto, senza riferimenti.
Il fortino malese non è molto conosciuto. Si trova infatti in una zona molto distante da quella dove noi abitualmente operiamo, quella cioè del nord, lungo tutta la linea di confine con l’Angola.
Ma tant’è. Helitaly non si è mai persa sinora e certamente non inizieremo noi oggi.
Costeggiamo l’unica strada asfaltata in direzione sud per 20/30 minuti e poi pieghiamo decisamente ad est, entrando nel bush.
In pochi minuti raggiungiamo il fortino malese e, dopo un paio di 360 sulla sua verticale, puntiamo ancora ad est, seguendo le tracce di un tratturo che ci porta ad un piccolo villaggio.
Ci appaiono una decina di capanne ai margini di un boschetto.
Mentre circuitiamo su di esso, notiamo un assembramento di persone ai suoi margini.
Sono immobili, come pietrificati ad osservare un penoso, orrendo spettacolo: tra il boschetto ed il sentiero che porta alle povere capanne, sparsi sul terreno sabbioso, giacciono i resti di alcune persone.
Andiamo all’atterraggio.
Un pensiero comune ci trattiene, improvviso, dal posare subito i pattini al suolo: “Occhio ragazzi, quello è un campo minato”, la frase che corre nell’interfono della crew.
Ma noi dobbiamo atterrare!
Allora cerchiamo con la massima attenzione delle tracce dove poter far posare, con ragionevole sicurezza, il nostro elicottero .
Notiamo delle tracce di ruote tassellate, quelle probabilmente di un mezzo pesante. Incrociando le dita ed elevando un pensiero alla nostra Santa Nera Protettrice, dal portellone aperto guido i piloti a posare i pattini esattamente sopra di esse.
E’ un momento pauroso ed eccitante allo stesso tempo!
La nostra buona stella ci assiste e finalmente a terra, possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo. Mentre i piloti tengono l’elicottero in moto al minimo, adesso tocca a me andare a vedere cosa è successo.
Ormai certo della protezione divina, con molta attenzione ed una buona dose di fatalismo, scendo dall’elicottero e mi avvio verso il luogo dell’esplosione.
Corpi lacerati: tre bambini sono esplosi su una mina del tipo di quelle che, calpestate, “saltano” fuori dal terreno per esplodere ad altezza del torace di un uomo.
Questi però sono bambini e l’altezza dell’esplosione è quella della loro testa. Per due di loro non c’è più nulla da fare, purtroppo. Uno però è ancora vivo, o almeno questa è la mia impressione, anche se in apparenza non dà grossi segni di vita. Non si lamenta nemmeno. Lo carico tra le braccia, un povero, lacero e leggero “fagotto” insanguinato, e faccio a ritroso, sulle mie orme precedenti, il tratto che mi separa dalla sicurezza del 205. Lo imbrago sulla barella e, con un rapido cenno ai piloti, rapidamente l’elicottero ridecolla. Un ultimo sguardo alla piccola folla – immobile e muta testimone delle operazioni di recupero – e già siamo lontani.
Durante i 40/50 minuti di volo che ci separano dall’ospedale svizzero di Oshakati cerco di dare un minimo di assistenza alla piccola vittima. Le pulisco il viso impastato di sabbia e sangue con un po’ d’acqua, cerco di tamponare al meglio le ferite, copro il corpicino tremante per le ferite e lo shock con una coperta. Non posso fare molto di più.
Ma ora lei comincia a lamentarsi ed a muoversi e ciò mi conferma la sua voglia di sopravvivere.
I piloti spingono l’elicottero al massimo della velocità consentita, pur volando sempre alla nostra consueta quota di 50 piedi – ce lo impone la minaccia dei Sam 7 -, consci che ogni minuto perso potrebbe essere quello fatale. Giungiamo infine all’ospedale, dove consegniamo la piccola vittima al personale sanitario. Viva!
Dopo un rapido saluto agli amici svizzeri, che tante volte hanno diviso con noi la rischiosa attività di MEDEVAC, decolliamo verso Ondangwa , verso “casa”. Un volo breve, di una quindicina di minuti, e siamo in base.
Mi resta da sistemare il velivolo, lavare la barella per ripulirla dalle tracce del sangue e della sabbia, rifornirlo ed ispezionarlo per un’altra evenienza che, fortunatamente, per oggi non accade.
Al tramonto, nel compound, ci raggiungerà la notizia che il nostro passeggero è sopravvissuto.
E’ una bimba.
Io, lo giuro, non me n’ero accorto.
Rivado con la memoria al film della giornata, alle emozioni, all’orrore ed alla paura vissuti.
La paura si supera, a volte. L’orrore si fa fatica a dimenticarlo.
Ma siano tornati tutti vivi e tanto anche per questa volta ci basta, malgrado tutto .
Vabbè – mi dico- è andata bene.
Domani si ricomincia.